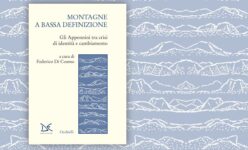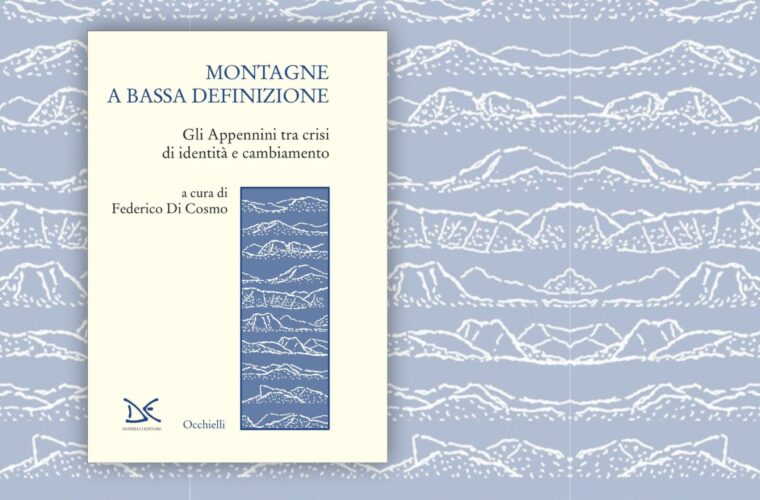23 novembre 1980. Appennino, una terra inquieta
di Giuseppe Lupo
(da Civiltà Appennino – R.Nigro e G.Lupo – Donzelli 2020)
Il sonno dei patriarchi
Conosco perfettamente ciò che avviene durante e dopo un terremoto: macerie, polvere, sangue, morti, speranze di trovare corpi vivi sotto le pietre, coraggio e paura, polemiche e sconforto. Queste sensazioni perciò mi vengono dettate da ragioni non tecniche, piuttosto da quel senso di insicurezza che rende fratelli tutti gli uomini di fronte alle catastrofi della natura e sotto certi aspetti apparenta in un unico destino di accettazione e di fatalismo le comunità cresciute ai piedi o sopra le cime di questo antico filare di montagne, le assimila fra loro anche se dislocate su paralleli diversi – da Reggio Emilia all’Aspromonte –, le fa riconoscere un insieme di individui sottomessi a una stessa legge.
Chi nasce sull’Appennino è abituato a sentire i sussulti della terra, convive con l’idea di una sicurezza perduta, si fa una ragione di questa instabilità che da geologica diventa esistenziale; addirittura, per celia, assimila il fenomeno delle scosse ai rigurgiti notturni, alle tossi, ai malanni che ogni tanto capitano alle persone anziane.
L’Appennino va interpretato anche così: è un nonno o un bisnonno dall’aspetto di un patriarca che dorme avvolto dal silenzio, ogni tanto si scuote, si volta sull’altro fianco nel letto, riprendendo il sonno. In questo essere un luogo anomalo rispetto a un’epoca come la nostra, terragno e non ancora liquido (forse liquido non lo sarà mai), in questo essere territorio dove il tempo transita più lentamente che altrove, sta la chiave di lettura attraverso cui comprendere le ragioni per cui chi ci abita ama rincorrere il mito di altre geografie, desidera fuggire verso il teorema di una modernità urbana e mercantile, vuole abbandonare case e terre in nome di un astratto dinamismo, di un bisogno di vita allegra.
L’Appennino è una terra che ogni tanto si scuote dal letargo e spinge i suoi figli verso altri mondi, è una culla da cui non ci si può non allontanare, se non altro per provare l’ebbrezza di Ulisse che deve conoscere il mondo, magari cadere anche nell’errore di sfidare gli dei, prima di assaporare la gioia del ritorno a Itaca. Però è anche un’arca di sogni e di desideri, un luogo di vigilie e di notti insonni, spese a progettare il futuro, a ipotizzare come sarà il domani.
Potrà sembrare un paradosso, ma è proprio sull’Appennino che fioriscono le utopie,
non nei luoghi di pianura o lungo le coste. Ne cito quattro: da Nomadelfia di don Zeno alla comunità di Monte Sole di Giuseppe Dossetti, dal cristianesimo come riattualizzazione del Vangelo riscritto da Francesco d’Assisi al cristianesimo come rifiuto di Celestino V. Sembra quasi che Dio parli con una lingua diversa, anzi che proprio lassù, sulla dorsale che segna trasversalmente l’Italia, avvenga il miracolo di una religione inedita. E a Carlo Levi, che nel 1945 aveva teorizzato l’assenza di Cristo (il suo Cristo si è fermato a Eboli non è altro che un teorema sulla latitanza di Dio, inteso come ragione e come processo storico, nelle antiche aree interne della Lucania), risponde trent’anni dopo Mario Pomilio con un libro a suo modo tellurico – Il quinto evangelio appunto – dove si presuppone una spasmodica ricerca di Cristo nei luoghi che da Bobbio discendono verso L’Aquila e Sulmona fino alle Calabrie.
Naturalmente dobbiamo pensare che quelle sull’Appennino siano «utopie di progetto» e non «utopie della fuga», sulla base della distinzione che Lewis Mumford operava in Storia dell’utopia (1922), dunque sono portatrici di una visione che non azzera la Storia, semmai si innerva ai suoi processi, ponendo gli autori appenninici in dimensione alternativa alle malinconie o ai fallimenti della Storia: da Raffaele Crovi a Paolo Volponi, da Silone a Pomilio, da Raffaele Nigro a Carmine Abate. Mi limito solo a pochi nomi, ma l’elenco andrebbe allungato in vista di questo problematico rapporto con la Storia.
La sensazione è che la sonnolenza dell’Appennino, l’antico dilemma che sfocia in tragedia quando accade un terremoto, sia il lievito di un nuovo giorno, quasi sedimentasse gli avvenimenti, amalgamasse le parole di un dizionario inedito, mescolasse i linguaggi che arrivano dall’accumulo di popoli sopraggiunti ad altri popoli, addormentasse i progetti. Poi però, come in un’epifania dopo l’attesa, i sogni covati nella cenere improvvisamente esplodono, il mondo vecchio lascia il posto a quello nuovo e il tempo accelera, ancora più di altre geografie.
Basta un terremoto e non solo il paesaggio, ma anche l’antropologia cambia, gli antichi borghi cessano di esistere, di essi rimangono solo le memorie che però sono il lievito del futuro.
Lo sguardo alla dimensione del mondo di ieri si confonde inevitabilmente nella tensione e nelle preoccupazioni di come sarà domani. Anche questo contiene lo strano dizionario del terremoto. Superata la fase delle lacrime, quando volteremo la pagina dei lutti e dei rimpianti, sarà necessario riscrivere il passato con una lingua che per forza di cose dovrà contenere i vocaboli della modernità. Ma è l’unica soluzione che ci rimane per non sentirci naufraghi e soli dentro il mare dell’esistenza.