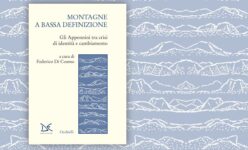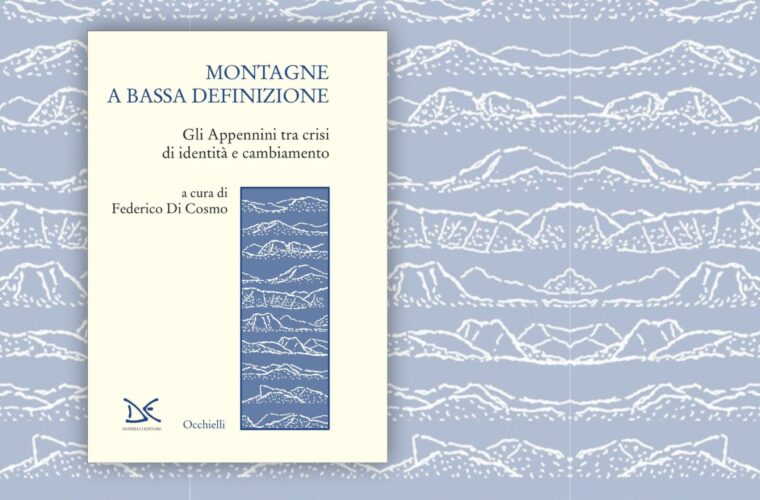Un punto interrogativo (rovesciato) in attesa di risposte
Nel loro insieme le montagne italiane – la struttura alpina e appenninica che sorregge il Paese come una spina dorsale – disegnano un punto interrogativo rovesciato, che ci interroga sul futuro di queste aree mentre sono ancora costrette a convivere con lo spopolamento, la perdita di funzioni e servizi. Si tratta di quello “spolpamento” oggetto qualche tempo fa di una riflessione di Piero Lacorazza, che è tornato poi sulla questione con “Ossi di polpa, il pieno dai vuoti” (Civiltà Appennino, 3 settembre 2021).
Non solo le “tre Italie” – scrive – o il dualismo tra Nord e Sud, ma un nuovo modo di rappresentare i divari, le disparità territoriali diventate inevitabilmente anche disuguaglianze sociali, misurabili nell’accesso ai diritti fondamentali e alle opportunità da parte degli abitanti delle zone interne.
Un approccio che condivido e che fa il paio con “i tanti sud dimenticati d’Italia, ovunque si trovino” dei quali ho parlato nel libro Un Paese di paesi. Luoghi e voci dell’Italia interna (ETS 2021). In questo schema l’Appennino si presenta come un insieme di paesi, boschi e campagne che hanno subito la dimenticanza e l’abbandono, vittime sacrificali di un modello di sviluppo che ha privilegiato le città, le coste e le poche pianure.
La riflessione di Lacorazza partiva da una bella rassegna di punti di vista, espressioni e concetti che invitano a superare lo schema dualistico o trialistico dell’Italia. È quanto è emerso anche nelle numerose iniziative che nel corso dell’estate 2021, ancora segnata dalla pandemia, si sono succedute nelle aree fragili, dal Nord al Sud, alimentando un confronto di idee ed esperienze forse senza precedenti, che ha portato studiosi, osservatori, amministratori e attori territoriali, ricercatori e artisti verso l’Appennino, nei paesi aggrappati alle pendici o distesi nei fondovalle interni. Lui cita lo Sponz Festival di Vinicio Capossela, al quale io non ho potuto partecipare per la concomitanza della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni” presso l’Istituto Alcide Cervi a Gattatico (RE), che quest’anno abbiamo dedicato proprio al paesaggio delle aree interne.
Altre occasioni di approfondimento a cui ho avuto modo di partecipare testimoniano di questo rinnovato fervore, probabilmente accelerato dall’emergenza sanitaria che ha messo in luce le contraddizioni del modello di vita consumistico e urbanocentrico, ma che al fondo esprime un bisogno di riequilibrio, con la necessità di tornare a considerare lo scheletro del Paese. Un Paese è un organismo vivente e l’Italia è un Paese particolarmente “vertebrato”, con una spina dorsale ben chiara costituita dalla catena appenninica: “il Bel Paese ch’Appennin parte” diceva Petrarca. Ma può un organismo vivente fare a meno del suo scheletro? Delle sue montagne e dei suoi corsi d’acqua che a pettine disegnano un territorio circondato dal mare, dei suoi molti paesi, delle sue connessioni che per secoli hanno tenuto insieme, in sistemi territoriali unici, costa ed entroterra, monti e pianure, città e campagne?
Nella Scuola di Fornara, organizzata dal Gruppo Emidio di Treviri ad Acquasanta Terme (AP), abbiamo osservato l’Appennino che cambia, che è anche il titolo di un volume frutto di un’esperienza collettiva di pratiche di ricerca e di azione condotta sulle conseguenze del terremoto del 2016 nell’Italia centrale. Meglio sarebbe dire i terremoti, perché oltre che dal terremoto vero – quello delle scosse, delle macerie e delle difficili ricostruzioni – queste aree sono afflitte in modo cronico da un altro terremoto, silenzioso e implacabile: l’abbandono e lo spaesamento. Lo spaesamento nel senso della perdita dell’orientamento, ma anche in quello più letterale della perdita del paese.
Un altro Festival denominato “Coralia” si è svolto a Tricalle, un quartiere periferico di Chieti che somiglia a un paese. Organizzato in un luogo recuperato all’uso pubblico da una cooperativa di comunità (Mirare), si è incentrato sul rapporto costa/entroterra, sull’importanza della geografia e sulla necessità di recuperare una sua visione “orizzontale”, che riconnetta i litorali con le montagne, con le valli che tornino ad essere arterie di un sistema complesso, correggendo un sistema tutto longitudinale che si è venuto consolidando con lo sviluppo contemporaneo.
La Scuola intitolata a Emilio Sereni, il più importante storico del paesaggio agrario italiano, ha preso il paesaggio come chiave per leggere il declino e le possibilità di rinascite delle aree interne, che sono nel loro insieme la parte più estesa del territorio italiano, quella delle colline e delle montagne, dei fiumi e delle paludi, cioè tutte quelle realtà essenzialmente rurali che sono state marginalizzate dal processo di sviluppo capitalistico e che oggi tornano alla ribalta come contenitori di patrimonio, risorsa per il futuro e ambiti di sperimentazione di un nuovo rapporto tra uomo e natura, a sua volta generatore di paesaggio, di economia, di società. Dunque, il paesaggio come specchio della marginalizzazione e come possibilità di lettura del patrimonio territoriale e della rigenerazione della grande periferia dello sviluppo, che può essere vista anche come un territorio vasto da cui ripartire.
Le aree interne non sono soltanto un’espressione geografica, ma una condizione esistenziale dei luoghi, di quelli che hanno conosciuto l’abbandono e la marginalizzazione, ampia parte di un Paese costituito quasi all’80 per cento da montagne e colline.
Si potrebbero passare in rassegna molte altre iniziative, formative, divulgative, di ricerca e di lotta, che dimostrano come l’Italia sia diventata piena e vuoto insieme: anzi, un accostamento squilibrato di troppo-pieni e troppo-vuoti. Il punto diventa allora riattivare le funzioni e le relazioni tra le sue diverse componenti territoriali, affinché come in un sistema di vasi comunicanti si riequilibri il Paese, un Paese che ha concentrato attività e popolazione nelle polpe, dimenticando l’osso, con processi di urbanizzazione e di litoralizzazione che hanno prodotto un effetto polarizzante, o un effetto ciambella, dimenticando lo storico policentrismo delle regioni italiane. Per farlo bisogna invertire lo sguardo, ma anche la rotta, sebbene il mare sia ancora incerto e il futuro ci appaia per larga parte ancora indecifrabile, seguendo la traiettoria di quel punto interrogativo montano che attende una risposta, anzi una varietà di risposte che seguano i caratteri e le specificità dei luoghi.
credits foto di copertina danfandor su Pixabay