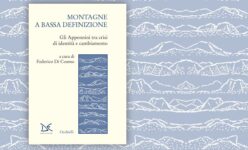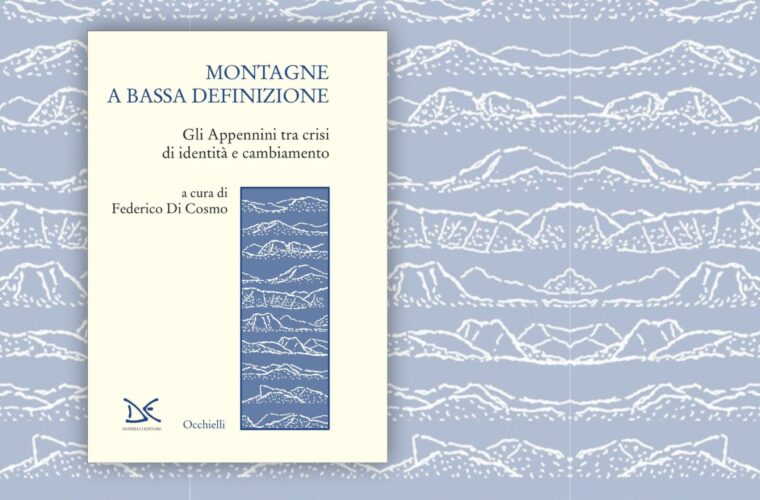Lavorare sui margini
Progetto di architettura e rigenerazione delle aree interne
di Antonio De Rossi e Laura Mascino
“I am located in the margin. I make a definite distinction between that marginality which is imposed by oppressive structures and that marginality one chooses as site of resistance – as location of radical openness and possibility”.
Bell Hooks, Choosing the Margin as a Space of Radical Openness, 1990
Mai, come oggi, la montagna e le aree interne sono state di moda, al centro di un dibattito che ha attraversato media e discussione pubblica. Certo, la pandemia ha funzionato da acceleratore. Ma questo è in realtà un tema che arriva da lontano, esito di una mutazione di immaginari e di rielaborazione culturale intorno agli assetti del territorio italiano che negli ultimi anni ha conosciuto appigli concreti, dalle policies messe in campo dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, fino alle centinaia di esperienze spontanee di rigenerazione che stanno attraversando borghi e paesi dell’intera penisola.
La pandemia ha cortocircuitato le crisi degli ultimi anni – quella ambientale, quella economica, ma anche quella intorno allo spazio generata dai modelli di sviluppo degli ultimi decenni – con l’emergere di nuove valenze e immaginari sulle aree interne. La débâcle sanitaria ha evidenziato quanto la dimensione spaziale e territoriale sia stata espulsa da tempo dalle policies di questo paese per essere ridotta a mero spazio diagrammatico e astratto. Una afisicità delle cose che attraversa anche le filosofie dello smart o delle best practices replicabili, nell’idea che sia sufficiente attenersi a una procedura per risolvere le complessità della contemporaneità.
L’astrazione dallo spazio fisico ha permesso quelle azioni di concentrazione (dell’eccellenza), separazione (dal territorio) e specializzazione (funzionale) che sono state la cifra delle trasformazioni recenti del nostro paese. Non è forse un caso che la crisi abbia colpito più duramente proprio in quei territori intermedi che sono stati i principali oggetti delle politiche settoriali.
Questa crescente consapevolezza non fa che rilanciare ulteriormente il tema delle aree interne. Nei primi mesi della crisi abbiamo così assistito a interventi che parlavano di far “adottare” i borghi delle aree interne dalle città metropolitane, affermando che il futuro del paese è nei territori di margine e non più nelle aree urbanizzate.
Al di là del diffuso wishful thinking che attraversa queste posizioni – che raramente si pongono il tema del come, e soprattutto rispetto a quali orizzonti economici e sociali, limitandosi a un mondo di immagini in fondo estetizzanti –, quello che colpisce sono gli immaginari sottesi a queste riflessioni, che sembrano sempre rimandare a una logica oppositiva e dicotomica dei territori, piuttosto che a un’idea cooperativa e della compresenza. Aut-aut invece che et-et. O la città, o la campagna-montagna. O i “centri”, o le “periferie”. O ancora le realtà metropolitane che “aiutano” le aree interne, come se queste fossero gusci vuoti, privi di comunità, progettualità, desideri, dotati solamente di patrimoni naturali e storici.
Eppure questi ultimi anni hanno mostrato quanto la frontiera dell’innovazione si sia venuta sovente a disporre proprio lungo le linee di margine: progetti di rigenerazione a base culturale, cooperative di comunità, processi di reinsediamento. Certo, si tratta di sperimentazioni fragili tanto quanto i luoghi su cui insistono, ma dove la dimensione spaziale gioca un ruolo attivo e inedito, che dovrebbe essere osservato con attenzione proprio in virtù delle nuove aperture che può offrire, anche rispetto a contesti urbani sempre più paralizzati.
Purtroppo nelle risposte finora offerte continua a prevalere quel paradigma tecnico-soluzionista privo di dimensione fisica che ha guidato il paese negli ultimi decenni. Eppure la crisi dimostra quanto la spazializzazione, la territorializzazione delle politiche oggi rappresenti una priorità decisiva. La pandemia ha infatti mostrato come le aree che hanno maggiore capacità di resistenza sono quelle dove buoni gradi di varietà e di interdipendenza delle parti vengono a coniugarsi con specifiche caratteristiche ambientali. È evidente come le aree interne abbiamo degli atouts da giocare in questa partita. Ma questo significa ridefinire in termini radicali molte delle policies dedicate a questi territori, quasi sempre incentrate sulla patrimonializzazione delle risorse locali e la loro valorizzazione turistica in fondo urbanocentrica. Dobbiamo rovesciare lo sguardo, come abbiamo tentato di dire col libro collettivo Riabitare l’Italia pubblicato presso Donzelli nel 2018: non a partire dai centri verso le periferie, ma a partire dai margini stessi. A muovere dall’idea che questi non debbano più essere meri luoghi del consumo (di natura, di paesaggi, di tradizioni), ma innanzitutto territori della produzione: di nuove culture, di innovazioni sociali, di saperi e pratiche tecnorurali, di rinnovati modi di fare welfare e di interagire con l’ambiente.
Tutto questo rischia però di rimanere astratta petizione di principio se non cambiano le culture e gli immaginari profondi. Paradossalmente questo paese, malgrado il suo incredibile mosaico paesaggistico, non ha mai coltivato un’idea di integrazione tra le sue parti. Serve una nuova visione metromontana e metrorurale, fondata sull’interdipendenza e la cooperazione dei diversi sistemi territoriali.
E serve, soprattutto, una nuova idea di abitabilità territoriale.
Dobbiamo smettere di parlare di ospedali, scuole, strade. Dobbiamo invece parlare di salute, di comunità educanti, di diritto alla mobilità e di accesso alle informazioni. Uscire dalla tassonomia degli oggetti precostituiti e dalla visione astratta delle soglie minime, e ricostruire modelli di infrastrutturazione e di welfare a partire dalle specificità dei territori. Innovando e contaminando.
Da questo punto di vista, la crisi mostra l’insensatezza di un dibattito sclerotizzato da anni sulla contrapposizione tra grandi e piccole opere infrastrutturali, dove il termine infrastruttura sembra essersi trasformato in una sorta di feticcio metafisico sganciato dalla realtà dei territori. Quello che questo paese necessita è un grande progetto di reinfrastrutturazione alle diverse scale che sappia tenere insieme dimensione logistica, ambientale e di welfare.
Ma affinché le aree interne non diventino l’ennesima riproposizione alla via italiana allo sviluppo incentrata sull’edilizia, serve un radicale cambiamento culturale. Qui c’è ben poco da costruire. Semmai c’è un immenso capitale fisso territoriale, fatto di borghi e sistemazioni agricole e fluviali, di boschi e infrastrutture minori, che attende di essere reinterpretato, riusato, mantenuto, innovato.
Da tempo ci interroghiamo sulla possibilità, operando in situazioni e contesti concreti, che il lavoro di progetto intorno ai margini consenta di liberare una differente visione del fare architettura, profondamente inscritta nella materialità delle cose, dei territori, delle comunità, dei processi. Come afferma Bell Hooks, il margine come spazio euristico dove praticare forme di radicale apertura e possibilità. Sono molte le discipline – da quelle storico-sociali fino a quelle scientifiche – che in anni recenti hanno fatto dello spazio di margine, di confine, un luogo privilegiato di indagine e ricerca.
Tra le molte di esperienze di rigenerazione in atto lungo le linee di margine delle aree interne, le migliori mostrano proprio questa inedita radice produttiva del progetto di architettura in rapporto ai patrimoni territoriali. Fuoriuscendo da un’accezione meramente culturalista e patrimonializzante, il palinsesto ereditato, nel farsi dell’atto rigenerativo, riacquisisce la sua valenza materica e concreta, diventando attore decisivo nei processi di riattivazione. I progetti fisici, le architetture, non sono più soltanto la mera traduzione di istanze funzionali e di sviluppo, ma diventano protagonisti proattivi e trainanti i processi rigenerativi. Un’architettura il cui valore non sta più solamente nelle sue intenzioni, ma nell’efficacia dei risultati e quindi negli effetti prodotti. Un lavoro progettuale di rigenerazione che pone l’accento più sul versante dell’interpretazione che su quello della trasformazione-costruzione, e che interseca continuamente, dall’interno dei processi, le dimensioni sociali, culturali e economiche, necessitando più delle figure del bricoleur e del mediatore che di quella di un progettista tradizionale. Innovazione a base culturale, nuove forme di agricoltura e di welfare, economie green e tecnorurali sono le matrici di questi percorsi di riattivazione.
- M. Crotti, A, De Rossi, M.-P. Forsans, Studio Gsp, Centro culturale Lou Pourtoun, Ostana
- M. Crotti, A. De Rossi, L. Dutto, Mizoun de la Villo-Casa alpina del Welfare, Ostana
Alcune esperienze di rigenerazione sul campo che portiamo avanti da tempo. A Ostana, paese occitano dell’alta valle Po, 1.200 abitanti nel 1921, 5 residenti fissi a fine secolo, l’architettura – insieme all’innovazione a base culturale – è stata decisiva per costruire un’infrastrutturazione di welfare, servizi, nuove microeconomie che ha sostenuto il processo di reinsediamento. Oggi Ostana ha nuovamente più di 50 abitanti, tendenzialmente giovani ad alto livello di scolarizzazione e con figli. Un caso per molti versi unico, dove molte volte sono stati gli stessi progetti fisici a orientare i percorsi di riattivazione, nello stretto dialogo quotidiano con la comunità locale. Tra le tante architetture che sono venute a creare questa infrastrutturazione diffusa il Centro culturale Lou Pourton, che riprende un antico principio insediativo del luogo per dare vita a una sorta di villaggio nel villaggio, una strada interna coperta circondata da “case” che contengono i vari spazi espositivi, formativi, laboratoriali gestiti dalla Cooperativa di comunità Viso a Viso. O ancora la Mizoun de la Villo, realizzata nel capoluogo, che oltre a riprendere la trama dei percorsi e spazi aperti dell’antico tessuto ospita – vera e propria casa pubblica del welfare – l’ambulatorio medico, un laboratorio artigianale, una biblioteca, spazi wellness. A queste costruzioni si aggiungono architetture a supporto della nuova agricoltura del luogo – come il caseificio con annessa casa del malgaro Tum/in –, strutture di servizio per il turismo green e slow, spazi comunitari e a supporto delle attività quotidiane.
Ma non c’è solo Ostana. Il lavoro prosegue anche in altre valli e realtà, sempre delineando strategie per la riattivazione e la rigenerazione a partire da precisi punti di leva progettuali e fisici, come a Dossena sulle Alpi Orobie in Lombardia o a Gagliano Aterno in Abruzzo, dove nuovamente la predisposizione di strutture per lo sviluppo culturale ed economico dei luoghi va di pari passo con la creazione di inediti spazi per la comunità locale. Un’idea di architettura non soltanto civile ma soprattutto produttiva che prefigura forse anche un modo nuovo di pensare il mestiere, dove l’esserci e il confronto serrato con l’esistente rappresentano questioni decisive.