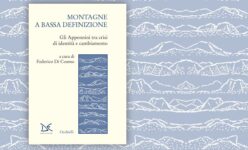Il cammino delle radici oltre l’Appennino
Storie di legami di sangue con le aree interne del Sud.
Ron Galella, Georges Brassens, John Giorno, Nunzio Gregorio Corso
di Nunzio Festa
Gli occhi e la voce gonfi delle immagini immerse nel reportage fotografico attraversante il mondo montuoso della Colombia di foreste e Farc, il fotografo pomaricano Leonardo Antonio Autera, illuminato spesso dal ricordo del suo maestro Helmut Newton, raccontava, oramai anni or sono, che la colonna vertebrale passante dai nostri piedi tocca esperienze di genialità e invenzione artistica poco note; Autera, insomma, per la prima volta nello specifico, sottolineava che a Muro Lucano era nato Vincenzo Galella, padre del Ron divenuto celebre con l’appellativo di “primo paparazzo”. Classe 1930, nato evidentemente negli States, appunto da genitori, entrambi, portatori d’origini anagrafiche e storiche italiane, Ron Galella è una delle figure maggiormente rappresentative dei figli di migranti italiani.
Celebrato da anni quindi a Muro, il cammino del sangue di Galella gli diede un giorno la possibilità d’inventarsi l’emersione dalla povertà, il riscatto dalla condizione di miseria presentatagli subito davanti. Quando, insomma, cominciò a pensare che spiare le star di tutti i campi dell’attenzione pubblica potesse renderli fama, e soprattutto fortuna economica, se resa curiosità estremizzata dal suo obiettivo della macchina fotografica. Se, insomma, fosse messa per sempre al bando quell’idea di discrezione custodita ma perfino coltivata nei paesi della montagna lucana, dove l’entroterra montano fa il paio con l’abitudine della discrezione quasi da clausura.
La dose d’Appennino di queste arrampicate, in fondo, sono la volontà d’ascesa verso una sommità rivolta al silenzio, alla contemplazione, alla quiete, persino alla pace se letta nella sua chiave minore di “tregua”; ché in alto ci si nasconde, ci s’è difesi. Perfino si scova il rifugio. Magari le star rincorse dal Galella, insomma, avessero avuto la possibilità di scampare oltre il sentire d’una vallata, entrando nel monte dalla porta della pianura.
Georges Charles Brassens, interprete e cantautore, oltre che poeta e attore francese nato a Sète, i cui testi sono spesso stati ripresi, com’è sempre più noto, da Fabrizio De André, anarchico intransigente, visse mettendo in poesia e nei suoi brani l’elogio per le porzioni d’umanità in contrasto assoluto con le regole e quelle infilate nei problemi di sopravvivenza, in specie le persone malamente considerate ultime d’ogni lista di categorie. I nonni materni di Georges Brassens erano nativi di Marsico Nuovo, dove avevano messo al mondo Elvira Dagrosa. La “città” di Marsico Nuovo è una costituita da una sfilata di frazioni che l’attaccano al alcuni paesini della Campania di filamento salernitano come agli altissimi potentini: Abriola, Brienza e Calvello.
Elvira, la mamma di Brassens, fin dai primi anni di vita di suo figlio gli cantava canzoni napoletane che lo formarono specie nei gusti, prima nei gusti. E le melodie che Brassens andrà amando negli anni della maturazione, le sonorità che sperimenterà nei suoi arrangiamenti innanzitutto eseguiti alla chitarra, rivedono le note colorate e sinuose di certe canzoni della tradizione napoletana più studiata e semplificata. Poi analizzata e riletta nella polvere artistica rappresentata dalla prima canzone d’autore francese e, in poesia, specialmente da Villon. In questa maniera, insomma, la soggettività dell’arte di Brassens si fa unica e universale. D’altronde, i sacrifici dei contadini e dei pastori di Marsico hanno rughe confacenti ai visi dell’umanità dei margini appenninici di tanti pezzetti d’Oltralpe.
Tursi ed Aliano sono stati fra gli ultimi territori terrestri e lunari esplorati dal poeta John Giorno, che nel paese della “casa con gli occhi”, l’Aliano dei festival moderni, girò, grazie al regista Antonello Faretta, un cortometraggio da vedere e rivedere. Un materiale che dovrebbe almeno andare a pareggiare l’importanza di certi scorci riprese dalle video-passeggiate neo-realiste realizzate ai tempi dello studioso meridionalista Ernesto De Martino. Oltre il concetto stesso d’etnografia. Salutando le dimestichezze dell’antropologia purissima. Un passo in più da lavoro di Franco Pinna.
Giorno, morto nel 2019, declama, in una viuzza d’Aliano, nel suo inglese accompagnato sempre dal corpo, a qualche millimetro da una signora d’altri tempi ma di questi anni seduta sull’uscio della sua casa, la poesia “Just Say NO to Family Value”.
La madre di J. Giorno, attore reso immortale e celebre già da decenni per merito di Andy Warhol, poeta della tempra di William Burroughs, era Maria Panevino (discendente d’una famiglia nobiliare, appunto, tursitana), nata sicuramente ad Aliano, mentre potrebbe aver avuto un nonno paterno stanziatosi a Nova Siri. E fu nella asperità proiettata verso le stelle già al passaggio degli arabi, oltre la dimora del Pierro, che Giorno fece un puntino del suo transito lucano titolato con Faretta “Nine Poems in Basilicata”. Nei cordoli dell’Appenino lucano inopportunamente spesso vidimato dal timbro d’una certa inferiorità. Eppure il film, opera d’arte fortunatamente premiata e circolata negli ambienti della critica seria, concede fari giovani ad Aliano, Tursi, Craco, Tricarico, Castelmezzano, Lagopesole, Venosa e Brienza. In più dei casi bocconi di Lucania ricorrenti al mistero protettivo dell’Appennino.
Amico di Ginsgber e Kerouac, stimato da Lawrence Ferlinghetti, vissuto fra i vicoli degli Stati Uniti e i boulevard di Parigi, fra miseria e poesia, Gregory Nunzio Corso ha invece sangue miglionichese da parte materna. Nel noto quartiere che fu dell’emigrazione italiana negli States, Little Italy, nel 1930, Gregory Nunzio Corso vide la luce d’una vita che diventerà intensissima e molto dura, infatti, dalla diciannovenne sbarcata nell’altrettanto nota Ellis Island, Michelina Colonna, da Miglionico (Matera). La famiglia Colonna fu una delle tante famiglie proletarie arrivate negli Usa a cercar fortuna, oppure semplicemente a cercare un miglioramento delle condizioni che sopportavano in questo caso nella via Castello della piccina Miglionico. Michelina, nata il 27 dicembre 1911 da Nunzio, contadino e facchino, figlio a sua volta di Michele e Lucrezia Terlimbacco e da Antonia Allegretti, contadina, trentaduenne, figlia a sua volta di Francesco e Carmina Consoli, si mossero in cerca della tanto agognata emancipazione economica. E viaggiarono verso le Americhe con le loro 4 figliolette. Carichi di speranze e prole.
In America Michelina Colonna aveva sposato Sam Corso, anche lui d’origini del Meridione italiano ma in questo caso delle zolle vitali calabre. Gregory Corso all’età di due anni finì in orfanotrofio. I suoi genitori s’erano separati. Il poeta di “Mindfield” (tradotto in italiano in “Corpo Mentale”), celebre nell’ex Belpaese per un’intervista, rilasciata a Gianni Minà in un noto programma Rai, dove era omaggiato da Fabrizio De André, ancora lui, e Mauro Pagani e per alcune letture di Vittorio Gassman dei suoi componimenti, viene da queste origini. La sua poesia germoglia lontano dalle geografie da mappa. I suoi versi salgono nelle strade e scendono nei viaggi faticosi di sopravvivenza e riflessioni. Vedi, su questo tema, il rapporto sempre conflittuale evidentemente con le guerre e i soprusi tutti. E le immagini tornano al cammino del sangue.
.
Credits: Foto copertina di Dariusz Sankowski da Pixabay