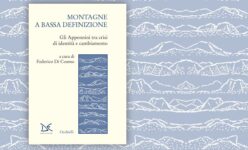Dai paesi dell’Appennino in America, la speranza è l’ultima a morire
A 130 anni dal naufragio del piroscafo Utopia
“Ho sentito un lamento
in mezzo alle onde
un lamento che ha reso più fioche
le nostre lampare.
Era forse il pianto della luna?
O era grido di stelle?
Erano angeli precipitati da lontane galassie
o demoni del mare
che davano sfogo a un antico dolore?”
(M. Sammartino)
Quieto viaggiava nel Mediterraneo, sul finire di un lungo inverno, il piroscafo partito da Fiume e Trieste per Palermo, e da qui per Messina e poi Napoli. Da Napoli, infine, la rotta verso New York, dove non giungerà, frantumato dal fato o da errore umano e inchiodato a quel “pianto clandestino che saliva dall’abisso”[1]!
Il 17 marzo del 1891, prima di varcare le Colonne d’Ercole, si consumava una delle più immani tragedie del mare: il piroscafo Utopia, una nave di 2731 tonnellate di stazza, della compagnia Britannica “Anchor Line”, che trasportava circa 900 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio, complice una forte tempesta e un’imprudente manovra del Capitano, nell’entrare nel porto di Gibilterra, finisce contro il rostro sottomarino della corazzata inglese Anson e lo squarcio laterale che si produce durante l’impatto determina una rapida inclinazione, di oltre 60 gradi, in meno di quindici minuti.
Il risultato è drammatico, muoiono quasi seicento persone, molte delle quali non faranno in tempo nemmeno a raggiungere il ponte dalle stive. Erano quasi tutti passeggeri di terza classe (solo tre i passeggeri di prima), ricchi di sola speranza, che viaggiavano dalle periferie d’Italia verso l’America alla ricerca di fortuna. È proprio tale composizione sociale che, probabilmente, determina il quasi completo oblio di questo terribile naufragio.
Chi erano, dunque, queste persone? Da dove venivano? Più facile immaginare di rispondere a queste domande guardando dove andavano, o meglio, dove avrebbero voluto andare. Raggiungere la “Merica” a bordo di “Tobia” (nome confidenziale con cui i contadini meridionali dei territori dell’entroterra chiamavano il piroscafo Utopia), rappresentava il compito precipuo di ciascuno di loro. E il viaggio veniva introiettato come parte integrante di quella avventura verso un’utopia, appunto, che per gli sfortunati migranti si trasformò letteralmente in un non-luogo. Un viaggio di molti giorni, nelle stive dove si accalcavano i viaggiatori di terza classe, in condizioni igieniche oltre i limiti dell’immaginabile. Un viaggio nella pancia della nave, in spazi piccolissimi colmi del putrido ciarpame e dei liquidi umani di ogni sorta che divenivano, sovente, causa di epidemie a bordo.
Eppure, abbandonare l’Appennino per sempre, o per poi, magari, un giorno ritornare, era vissuto come una possibilità di salvezza dalla miseria materiale che condizionava la vita di ciascuno. E così da Barrea e da Fraine in Abruzzo, da Pietrabbondante e Isernia in Molise, da Grottaminarda e Calitri in Campania, da Pomarico e Calvello in Basilicata, da Faeto e da Roseto Val Fortore in Puglia, da Marano Marchesato e da Pentone in Calabria, da Lucca Sicula e da Mezzojuso in Sicilia e da molti altri comuni, soprattutto della dorsale montuosa italiana, meridionale, truppe di contadini diventavano emigranti verso il nuovo mondo. Schiere di camminatori di terre montuose, braccianti, zappatori, con una forte speranza in cuore, che s’improvvisavano naviganti per un destino nuovo, cangiante sotto la luce di un nuovo continente da scoprire.
A quel tempo mancava ancora una legislazione specifica che trattasse i migranti come persone. Gli umani viaggianti erano considerati alla stregua di merci. Non a caso il codice giuridico di riferimento è stato, fino a inizio del ‘900, quello della marina mercantile. E l’Utopia, oltre che uomini, trasportava infatti prugne, arance e altra frutta.
Dopo il tremendo impatto con la corazzata inglese, il mare sommerse rapidamente la poppa del piroscafo, e dopo circa 30 minuti fu sommersa anche la prua. Rimanevano fuori dall’acqua soltanto i due alberi maggiori (l’Utopia aveva viaggiato a vela fino a qualche anno prima e gli alberi non furono mai rimossi dalla struttura) e la ciminiera del vapore. Chi si trovò sballottato in mare dovette lottare contro onde tremende. L’equipaggio e i passeggeri si precipitarono sugli alberi e sui pennoni, e i più intrepidi si gettarono in mare, dove la maggior parte di loro trovò morte istantanea, furono pochi coloro che riuscirono a salvarsi.
Nel momento funesto, la Capitaneria di Porto inviò la propria lancia per prestare soccorso e così fecero le navi da guerra e le altre navi del porto che avevano possibilità di farlo, era un via vai di battelli a vapore e scialuppe di salvataggio in aiuto degli sfortunati naufraghi.

Fig.2 – I drammatici momenti del naufragio del piroscafo Utopia all’ingresso del porto di Gibilterra. Immagine tratta da “L’Illustrazione popolare. Giornale per le famiglie” del 12 aprile 1891.
I soccorsi risultarono piuttosto complicati a causa delle pessime condizioni del mare, che misero a serio rischio tutti coloro che tentarono di avvicinarsi all’Utopia. A tal proposito occorre ricordare che perirono anche dei marinai inglesi intenti a soccorre i naufraghi. Sappiamo, dai racconti dei testimoni, che le grida pietose dei naufraghi risuonavano nello spazio, rendendo lo spettacolo sempre più tetro. Alcuni cadaveri galleggiavano sull’acqua, molti altri, invece, furono trovati a riva solo nei giorni successivi; naufraghi che lottavano, stremati dalla fatica, con le onde impetuose, alcuni avevano trovato posto, aggrappati, sugli ultimi pennoni liberi e ancora fuori dall’acqua del piroscafo. Tra questi una vera e propria lotta per rimanere aggrappati ai pali, sferrando calci e pugni a chi provava a sottrargli faticosamente lo spazio aereo in cima all’albero per salvarsi, nel mentre tutti imploravano aiuto, supplicando di essere salvati da una orribile fine.
Il primo sommozzatore che il giorno dopo il naufragio raggiunse la pancia del piroscafo racconta scene terribili, riferendosi a una vera e propria massa umana sottocoperta, che si teneva a pali e corde, una donna con stretto il figlio al petto. Un’agghiacciante scena di morte!
I superstiti, tutti amorevolmente soccorsi, furono curati tra Gibilterra e le cittadine spagnole a ridosso del promontorio sede del protettorato britannico e, dopo alcuni giorni, furono invitati a tornare a Napoli con il piroscafo Assirya o a proseguire per New York col piroscafo Anglia.
Negli anni successivi fu un lunghissimo processo, quello attraverso il quale si provò a ottenere un risarcimento per le vittime del naufragio, Imponente fu la struttura della difesa della Compagnia navale Anchor Line e degli Henderson Brothers, gli armatori del piroscafo.
Ci provarono il lucano Emanuele Gianturco (in seguito Ministro per vari Governi) e i suoi colleghi legali a far ottenere un risarcimento alle famiglie delle vittime ma, la lunga mano della Corona inglese, presumibilmente attivando anche i servizi segreti, sostenne indirettamente la compagnia di navigazione e i suoi armatori per evitare di creare un pericoloso precedente che avrebbe potuto compromettere i grossi affari speculativi di tutto quel mondo che orbitava intorno alla miseria e all’utopia di chi intendeva ricostruire una possibilità altra da quella della miseria stessa da cui fuggiva[2].
Note:
[1] Mimmo Sammartino – «Un canto clandestino saliva dall’abisso» Sellerio editore, Palermo 2006
[2] A riguardo del naufragio dell’Utopia l’autore dell’articolo sta scrivendo un lavoro a conclusione di un lungo periodo di ricerca in molti archivi.
Credits foto: Immagini fornite da Gianni Palumbo
Copertina. Fig. 1 – Cartolina postale che illustra il momento dopo l’impatto del piroscafo Utopia con la corazzata della Marina Militare inglese, Anson. Sono i fari della stessa Hanson e di altre navi militari a permettere le operazioni di soccorso nella burrascosa sera del porto di Gibilterra.
Fig.2 – I drammatici momenti del naufragio del piroscafo Utopia all’ingresso del porto di Gibilterra. Immagine tratta da “L’Illustrazione popolare. Giornale per le famiglie” del 12 aprile 1891.