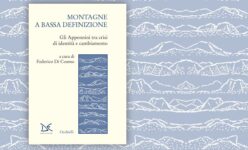L’identità di un’Italia verticale che unisce Europa e Mediterraneo
Di Raffaele Nigro
(tratto da Civiltà Appennino – L’Italia verticale tra identità e rappresentazioni – Donzelli Editore, Roma 2020)
Guardo la penisola con le spalle al Mediterraneo e gli occhi all’Europa.
Ho di fronte un tentativo complicato di riunire gli Stati europei in una confederazione sempre più spaccata da vicende storiche diverse. Ho di fronte a me un’organizzazione politica decisa a tagliare la penisola in due tronconi e a chiudersi progressivamente in una fortezza economica che intende sfidare anche l’eternità.
Quella moria lenta dell’impero austroungarico così ben definita da Claudio Magris si è andata cristallizzando in una congerie di paesi spaventati dalle invasioni extracomunitarie e vicine al carattere arcigno e reazionario della Gran Bretagna. Alle mie spalle c’è invece un continente agitato da un pulviscolo di paesi di diversa colorazione culturale ed economica che guardano al vecchio continente come alla meta negata della felicità.
Ma davanti a me c’è anche una penisola lunga, sezionata in aree storicamente segnate da divisioni antiche e che da tempo provo a guardare secondo una visione politica e geografica non più strutturata in Italia settentrionale, centrale e meridionale.
L’ immagine di una finestra spalancata su un universo nuovo o su un modo diverso di concepire il futuro. A cominciare dal beneficio che portano l’aria pura, i cibi sani, una concezione più lenta della vita. La vera guerra aperta alle pestilenze del cancro e della nevrosi.
Mi appare allora una cultura tirrenica alla mia sinistra, una adriatica a destra e il grande Appennino al centro. Questa catena di montagne, di valli, di colline funge, nella mia lettura geografica dei due continenti che ho sotto i piedi e davanti agli occhi, come un’ascissa terrosa e floristica che lega l’Europa e il Mediterraneo.
Il Sud è storicamente il luogo della povertà e della fuga. Il Nord quello della ricchezza e oggi della difesa ad oltranza dei confini. A questa arteria montana gli abitanti dei S4ud mediterranei si aggrappano, intenzionati ad attraversarla tutta o in parte per cercare una vita diversa, a volte il respiro della stessa vita.
Mi appare dunque un’Italia lunga e in piedi, un’Italia verticale, un colosso di Rodi con la testa nelle pianure dell’Europa e i piedi nel Mediterraneo.
Queste tre fasce geografiche hanno espresso nei secoli altrettante forme di culture e di strutturazioni del territorio, che oggi vogliamo definire e descrivere nelle loro diversità e peculiarità, convinti che una riflessione intorno al loro modo di presentarsi dia vita a un approccio culturale economico e politico assolutamente diversificato e tale da far superare quella separatezza che l’Italia ha vissuto e vive tra un paese di polentoni e uno di terroni, tra un mondo borbonico, uno papalino e uno leghista.
Cominciamo da sinistra.
Trovo che il Tirreno abbia prodotto una cultura creativa, della ricerca di luoghi lontani, stimolata dall’immensità del mare, il luogo della mente che si aggetta verso la Spagna e di lì verso l’Atlantico, il luogo della mente inquieta, che cerca, animata dalla poesia, dal sentimento, dal sogno e dalla fantasia. Il Tirreno, con le sue coste a picco ha fatto sentire gli abitatori dell’area come schiacciati contro il mare, li ha visti sempre in posizione di fuga, come pronti per spiccare un salto. Le Repubbliche marinare in primis. La mente febbrile di Caboto e Colombo a seguire. E poi l’ansia e la disperazione di chi lasciava Napoli per l’America, dove si andava a cercare fortuna. E poi le grandi flotte dei Doria e dei Costa, approdate in tempi moderni nelle navi della Costa Crociere e della MSC.
Il Tirreno è anche il mare su cui, purtroppo, sono approdati i fenomeni malavitosi fioriti in Spagna e migrati in Italia a partire dal Trecento. La conquista spagnola dell’Italia meridionale ha fatto sì che il malaffare si aggrappasse alle nostre coste e seminasse in Campania la camorra. Cui hanno fatto seguito, nell’Ottocento la mafia in Sicilia e dai primi del Novecento la ‘ndrangheta in Calabria. Sono consequenziali? Io non lo so, sta di fatto che i tre fenomeni malavitosi hanno aggredito e abitato tutta la costa meridionale del Tirreno. Tutti e tre nell’antico Vicereame e nel Reame. Da dove si sono poi diffusi nel mondo intero. Creando forme di Stato nello Stato e di bubboni creativi ma violenti e parassitari. Il Viceregno era un governo che agiva per conto del Re lontano e che aveva il compito di spremere le casse dei regnicoli. I quali hanno praticato l’arte dell’inganno nei confronti di uno Stato che non sentivano come proprio. Un’arte che ha prodotto una forma di disprezzo e di sottrazione delinquenziale alle leggi. Ciò che si continua a praticare al giorno d’oggi e che si è fatta globale.
Sull’Adriatico si è impiantata invece una cultura del commercio e del contrabbando. Lo stesso che si praticava nelle zone di confine delle Alpi.
C’era un tempo il mare di Venezia, una Repubblica che fondava sui commerci e sulla conquista dei mercati la propria politica. La strettoia del mare non permetteva che nascessero altri mercanti e neppure grandi viaggiatori marini. Gli statuti marinari di Trani furono bloccati dai veneziani e Bari, che ebbe qualche fortuna nel Medioevo, cominciò a temere il mare con i Turchi. “All’armi all’armi la campana sona/ so’ sbarcati li Turchi alla marina!”.
Una spinta alla conoscenza non mancò tuttavia anche su questo mare. La praticò Marco Polo, ma da giovane rampollo di una famiglia di mercanti provò a cercare a dorso di cavalli luoghi di compravendita in Estremo Oriente. Mentre padre Matteo Ricci partì per obbedire ai progetti di evangelizzazione dettati da Ignazio di Loyola.
In generale Venezia operava una politica di conquista e di dominio. Penso ai Balcani, all’Albania, a Corfù. E in questa operatività le razzie e i furti praticati da marinai adriatici divennero memorabili con le spoglie di san Matteo, san Nicola, santa Eufemia, san Trifone.
Ma nel Centro e nel Sud dell’Adriatico ancora oggi la mercatura è quotidiana, e quotidiani gli scambi. Magari non si accarezzano grandi idee e grandi progetti. Anche adesso, nonostante trent’ anni di arrivi dalle sponde balcaniche, la vicinanza non ha mai suggerito forme di sopraffazione economica e i nostri cuochi hanno aperto ristoranti in quei paesi. Perché la costa balcanica ha sempre avuto rapporti di scambio con l’Italia, dalle invasioni degli Illiri alla civiltà dei Romani e poi su verso Ladislao di Durazzo signore anche di Napoli, fino a Scanderbeg che si riconosce vassallo degli Aragonesi e a Bona Sforza regina di Polonia e poi ancora a Elena di Montenegro e Sofia d’Austria che il giovane Franceschiello venne ad aspettare sul porto di Bari. Un sogno di impero ci fu solo durante il fascismo, ma fu un fenomeno finito in burletta se non in tragedia.
Al centro dei due schieramenti marini resta un territorio alpestre e boschivo che è la spina dorsale dell’Italia, è l’Appennino.
Una catena di montagne che ritengo esprima da sempre una cultura uniforme dalle Langhe all’Aspromonte e ai monti Iblei. L’uniformità si legge in una serie di aspetti che costituiranno, seppure in maniera non esaustiva, i vari capitoli di questo libro e che fanno dell’Appennino un unicum antropologico letterario botanico faunistico e urbanistico. Un unicum che ha generato anche una scrittura legata alle radici e al localismo, a dispetto di un globale che sta uccidendo le specificità della tradizione.